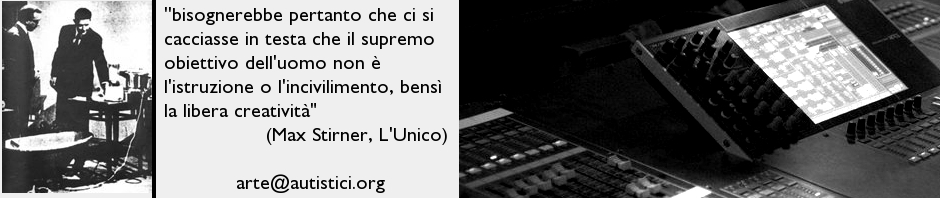Fino a pochi decenni fa i Siciliani andavano per il mondo in cerca di lavoro e novità. Fino agli anni ’50 e ’60, le navi erano ancora un mezzo molto usato per andare nelle Americhe a cercar fortuna: si vendeva tutto prima di partire o si lasciava moglie e figli in paese per prenderli dopo qualche anno di duro lavoro.
Cose scontate. Tutti noi abbiamo dei parenti che sono andati, magari non più tornati e magari divenuti razzisti nei confronti degli Indigeni in Venezuela o degli Afro-Americani negli USA; non sporcano la loro bastarda razza Sicula con questa gente rozza, non lo fanno se vogliono tenere ben saldi i legami con la famiglia d’origine.
D’estate alcuni tornano in paese, parlano un dialetto stretto e comico, ricordano ancora i carreti con i pennacchi e trovano ragazzini con la cresta e il videofonino. Portano ancora gomme da masticare, sigarette americane e le donne si truccano in un modo sconvolgente.
Sciascia ha scritto un breve racconto intitolato "il viaggio più lungo", una storia che tratta di un viaggio clandestino di Siciliani in procinto di salpare per le Americhe che si conclude comicamente nel mio paese d’origine Santa Croce Camerina (RG). Non vi ho svelato niente tranquilli!
Leggendo queste tre paginette, mi sono ricordato quel lontano sbarco a Punta Secca, quando un centinaio tra donne, bambini e uomini ci sbarcarono sotto il naso e quando gli sbirri arrivarono e ci allontanarono con la forza per portarli tutti in quel CPT di Ragusa dove poi ci siamo presi la denuncia fantasma…vabbè lasciamo perdere…
buona lettura

Era una notte che pareva fatta apposta, un’oscurità cagliata che a muoversi quasi se ne sentiva
il peso. E faceva spavento, respiro di quella belva che era il mondo, il suono del mare: un respiro che
veniva a spegnersi ai loro piedi.
il peso. E faceva spavento, respiro di quella belva che era il mondo, il suono del mare: un respiro che
veniva a spegnersi ai loro piedi.
Stavano, con le loro valige di cartone e i loro fagotti, su un tratto di spiaggia pietrosa, riparata da colline,
tra Gela e Licata; vi erano arrivati all’imbrunire, ed erano partiti all’alba dai loro paesi; paesi interni, lontani
dal mare, aggrumati nell’arida plaga del feudo. Qualcuno di loro, era la prima volta che vedeva il mare: e
sgomentava il pensiero di dover attraversarlo tutto, da quella deserta spiaggia della Sicilia, di notte, ad
un’altra deserta spiaggia dell’America, pure di notte. Perché i patti erano questi – Io di notte vi imbarco –
aveva detto l’uomo: una specie di commesso viaggiatore per la parlantina, ma serio e onesto nel volto – e
di notte vi sbarco: sulla spiaggia del Nugioirsi, vi sbarco; a due passi da Nuovaiorche… E chi ha parenti in
America, può scrivergli che aspettino alla stazione di Trenton, dodici giorni dopo l’imbarco… Fatevi il conto
da voi… Certo, il giorno preciso non posso assicurarvelo: mettiamo che c’è mare grosso, mettiamo che la
guardia costiera stia a vigilare… Un giorno più o un giorno meno, non vi fa niente: l’importante è sbarcare
in America.
L’importante era davvero sbarcare in America: come e quando non aveva poi importanza. Se ai loro
parenti arrivavano le lettere, con quegli indirizzi confusi e sgorbi che riuscivano a tracciare sulle buste,
sarebbero arrivati anche loro; “chi ha lingua passa il mare”, giustamente diceva il proverbio. E avrebbero
passato il mare, quel grande mare oscuro; e sarebbero approdati agli stori alle farme dell’America,
all’affetto dei loro fratelli zii nipoti cugini, alle calde ricche abbondanti case, alle automobili grandi come
case.
Duecentocinquantamila lire: metà alla partenza, metà all’arrivo. Le tenevano, a modo di scapolari, tra la
pelle e la camicia. Avevano venduto tutto quello che avevano da vendere, per racimolarle: la casa terragna
il mulo l’asino le provviste dell’annata il canterano le coltri. I più furbi avevano fatto ricorso agli usurai, con
la segreta intenzione di fregarli; una volta almeno, dopo anni che ne subivano angaria: e ne aveva
soddisfazione, al pensiero della faccia che avrebbero fatta nell’apprendere la notizia. “Vieni a cercarmi in
America, sanguisuga: magari ti ridò i tuoi soldi, ma senza interesse, se ti riesce di trovarmi”. Il sogno
dell’America traboccava di dollari: non più, il denaro, custodito nel logoro portafogli o nascosto tra la
camicia e la pelle, ma cacciato con noncuranza nelle tasche dei pantaloni, tirato fuori a manciate: come
avevano visto fare ai loro parenti, che erano partiti morti di fame, magri e cotti dal sole; e dopo venti o
trent’anni tornavano, ma per una breve vacanza, con la faccia piena e rosea che faceva bel contrasto coi
capelli candidi.
Erano già le undici. Uno di loro accese la lampadina tascabile: il segnale che potevano venire a
prenderli per portarli sul piroscafo. Quando la spense, l’oscurità sembrò più spessa e paurosa. Ma qualche
minuto dopo, dal respiro ossessivo del mare affiorò un più umano, domestico suono d’acqua: quasi che vi
si riempissero e vuotassero, con ritmo, dei secchi. Poi venne un brusìo, un parlottare sommesso. Si
trovarono davanti il signor Melfa, che con questo nome conoscevano l’impresario della loro avventura,
prima ancora di aver capito che la barca aveva toccato terra.
– Ci siamo tutti? – domandò il signor Melfa. Accese la lampadina, fece la conta. Ne mancavano due. –
Forse ci hanno ripensato, forse arriveranno più tardi… Peggio per loro, in ogni caso. E che ci mettiamo ad
aspettarli, col rischio che corriamo?
Tutti dissero che non era il caso di aspettarli.
Se qualcuno di voi non ha il contante pronto – ammonì il signor Melfa – è meglio si metta la strada tra le
gambe e se ne torni a casa: che se pensa di farmi a bordo la sorpresa, sbaglia di grosso: io vi riporto a
terra com’è vero dio, tutti quanti siete. E che per uno debbano pagare tutti, non è cosa giusta: e dunque
chi ne avrà colpa la pagherà per mano mia e per mano dei compagni, una pestata che se ne ricorderà
mentre campa; se gli va bene…
Tutti assicurarono e giurarono che il contante c’era, fino all’ultimo soldo.
– In barca – disse il signor Melfa. E di colpo ciascuno dei partenti diventò una informe massa, un
confuso grappolo di bagagli.
– Cristo! E che vi siete portata la casa appresso? – cominciò a sgranare bestemmie, e finì quando tutto
il carico, uomini e bagagli, si ammucchiò nella barca: col rischio che un uomo o un fagotto ne traboccasse
fuori. E la differenza tra un uomo e un fagotto era per il signor Melfa nel fatto che l’uomo si portava
appresso le duecentocinquatamila lire; addosso, cucite nella giacca o tra la camicia e la pelle. Li
conosceva, lui, li conosceva bene: questi contadini zoticoni, questi villani.
tra Gela e Licata; vi erano arrivati all’imbrunire, ed erano partiti all’alba dai loro paesi; paesi interni, lontani
dal mare, aggrumati nell’arida plaga del feudo. Qualcuno di loro, era la prima volta che vedeva il mare: e
sgomentava il pensiero di dover attraversarlo tutto, da quella deserta spiaggia della Sicilia, di notte, ad
un’altra deserta spiaggia dell’America, pure di notte. Perché i patti erano questi – Io di notte vi imbarco –
aveva detto l’uomo: una specie di commesso viaggiatore per la parlantina, ma serio e onesto nel volto – e
di notte vi sbarco: sulla spiaggia del Nugioirsi, vi sbarco; a due passi da Nuovaiorche… E chi ha parenti in
America, può scrivergli che aspettino alla stazione di Trenton, dodici giorni dopo l’imbarco… Fatevi il conto
da voi… Certo, il giorno preciso non posso assicurarvelo: mettiamo che c’è mare grosso, mettiamo che la
guardia costiera stia a vigilare… Un giorno più o un giorno meno, non vi fa niente: l’importante è sbarcare
in America.
L’importante era davvero sbarcare in America: come e quando non aveva poi importanza. Se ai loro
parenti arrivavano le lettere, con quegli indirizzi confusi e sgorbi che riuscivano a tracciare sulle buste,
sarebbero arrivati anche loro; “chi ha lingua passa il mare”, giustamente diceva il proverbio. E avrebbero
passato il mare, quel grande mare oscuro; e sarebbero approdati agli stori alle farme dell’America,
all’affetto dei loro fratelli zii nipoti cugini, alle calde ricche abbondanti case, alle automobili grandi come
case.
Duecentocinquantamila lire: metà alla partenza, metà all’arrivo. Le tenevano, a modo di scapolari, tra la
pelle e la camicia. Avevano venduto tutto quello che avevano da vendere, per racimolarle: la casa terragna
il mulo l’asino le provviste dell’annata il canterano le coltri. I più furbi avevano fatto ricorso agli usurai, con
la segreta intenzione di fregarli; una volta almeno, dopo anni che ne subivano angaria: e ne aveva
soddisfazione, al pensiero della faccia che avrebbero fatta nell’apprendere la notizia. “Vieni a cercarmi in
America, sanguisuga: magari ti ridò i tuoi soldi, ma senza interesse, se ti riesce di trovarmi”. Il sogno
dell’America traboccava di dollari: non più, il denaro, custodito nel logoro portafogli o nascosto tra la
camicia e la pelle, ma cacciato con noncuranza nelle tasche dei pantaloni, tirato fuori a manciate: come
avevano visto fare ai loro parenti, che erano partiti morti di fame, magri e cotti dal sole; e dopo venti o
trent’anni tornavano, ma per una breve vacanza, con la faccia piena e rosea che faceva bel contrasto coi
capelli candidi.
Erano già le undici. Uno di loro accese la lampadina tascabile: il segnale che potevano venire a
prenderli per portarli sul piroscafo. Quando la spense, l’oscurità sembrò più spessa e paurosa. Ma qualche
minuto dopo, dal respiro ossessivo del mare affiorò un più umano, domestico suono d’acqua: quasi che vi
si riempissero e vuotassero, con ritmo, dei secchi. Poi venne un brusìo, un parlottare sommesso. Si
trovarono davanti il signor Melfa, che con questo nome conoscevano l’impresario della loro avventura,
prima ancora di aver capito che la barca aveva toccato terra.
– Ci siamo tutti? – domandò il signor Melfa. Accese la lampadina, fece la conta. Ne mancavano due. –
Forse ci hanno ripensato, forse arriveranno più tardi… Peggio per loro, in ogni caso. E che ci mettiamo ad
aspettarli, col rischio che corriamo?
Tutti dissero che non era il caso di aspettarli.
Se qualcuno di voi non ha il contante pronto – ammonì il signor Melfa – è meglio si metta la strada tra le
gambe e se ne torni a casa: che se pensa di farmi a bordo la sorpresa, sbaglia di grosso: io vi riporto a
terra com’è vero dio, tutti quanti siete. E che per uno debbano pagare tutti, non è cosa giusta: e dunque
chi ne avrà colpa la pagherà per mano mia e per mano dei compagni, una pestata che se ne ricorderà
mentre campa; se gli va bene…
Tutti assicurarono e giurarono che il contante c’era, fino all’ultimo soldo.
– In barca – disse il signor Melfa. E di colpo ciascuno dei partenti diventò una informe massa, un
confuso grappolo di bagagli.
– Cristo! E che vi siete portata la casa appresso? – cominciò a sgranare bestemmie, e finì quando tutto
il carico, uomini e bagagli, si ammucchiò nella barca: col rischio che un uomo o un fagotto ne traboccasse
fuori. E la differenza tra un uomo e un fagotto era per il signor Melfa nel fatto che l’uomo si portava
appresso le duecentocinquatamila lire; addosso, cucite nella giacca o tra la camicia e la pelle. Li
conosceva, lui, li conosceva bene: questi contadini zoticoni, questi villani.
Il viaggio durò meno del previsto: undici notti, quella della partenza compresa. E contavano le notti
invece che i giorni, poiché le notti erano di atroce promiscuità, soffocanti. Si sentivano immersi nell’odore
di pesce di nafta e di vomito come in un liquido caldo nero bitume. Ne grondavano all’alba, stremati,
quando salivano ad abbeverarsi di luce e di vento. Ma come l’idea del mare era per loro il piano
verdeggiante di messe quando il vento lo sommuove, il mare vero li atterriva: e le viscere gli si strizzavano,
gli occhi dolorosamente verminavano di luce se appena indugiavano a guardare.
Ma all’undicesima notte il signor Melfa li chiamò in coperta: e credettero dapprima che fìtte costellazioni
fossero scese al mare come greggi; ed erano invece paesi, paesi della ricca America che come gioielli
brillavano nella notte. E la notte stessa era un incanto: serena e dolce, una mezza luna che trascorreva tra
una trasparente fauna di nuvole, una brezza che allargava i polmoni.
– Ecco l’America – disse il signor Melfa.
– Non c’è pericolo che sia un altro posto? – domandò uno: poiché per tutto il viaggio aveva pensato che
nel mare non ci sono nè strade nè trazzere, ed era da dio fare la via giusta, senza sgarrare, conducendo
una nave tra cielo ed acqua.
Il signor Melfa lo guardò con compassione, domandò a tutti – E lo avete mai visto, dalle vostre parti, un
orizzonte come questo? E non lo sentite che l’aria è diversa? Non vedete come splendono questi paesi?
Tutti convennero, con compassione e risentimento guardarono quel loro compagno che aveva osato
una così stupida domanda.
– Liquidiamo il conto – disse il signor Melfa.
Si frugarono sotto la camicia, tirarono fuori i soldi.
– Preparate le vostre cose – disse il signor Melfa dopo avere incassato.
Gli ci vollero pochi minuti: avendo quasi consumato le provviste di viaggio, che per patto avevano
dovuto portarsi, non restava loro che un po’ di biancheria e i regali per i parenti d’America: qualche forma
di pecorino qualche bottiglia di vino vecchio qualche ricamo da mettere in centro alla tavola o alle spalliere
dei sofà. Scesero nella barca leggeri leggeri, ridendo e canticchiando; e uno si mise a cantare a gola
aperta, appena la barca si mosse.
E dunque non avete capito niente? – si arrabbiò il signor Melfa. – E dunque mi volete fare passare il
guaio?… Appena vi avrò lasciati a terra potete correre dal primo sbirro che incontrate, e farvi rimpatriare
con la prima corsa: io me ne fotto, ognuno è libero di ammazzarsi come vuole… E poi, sono stato ai patti:
qui c’è l’America, il dovere mio di buttarvici l’ho assolto… Ma datemi il tempo di tornare a bordo, Cristo di
Dio!
Gli diedero più del tempo di tornare a bordo: che rimasero seduti sulla fresca sabbia, indecisi, senza
saper che fare, benedicendo e maledicendo la notte: la cui protezione, mentre stavano fermi sulla
spiaggia, si sarebbe mutata in terribile agguato se avessero osato allontanarsene.
Il signor Melfa aveva raccomandato – sparpagliatevi – ma nessuno se la sentiva di dividersi dagli altri. E
Trenton chi sa quant’era lontana, chi sa quando ci voleva per arrivarci.
Sentirono, lontano e irreale, un canto. “Sembra un carrettiere nostro”, pensarono: e che il mondo è
ovunque lo stesso, ovunque l’uomo spreme in canto la stessa malinconia, la stessa pena.
Ma erano in America, le città che baluginavano dietro l’orizzonte di sabbia e d’alberi erano città
dell’America.
Due di loro decisero di andare in avanscoperta. Camminarono in direzione della luce che il paese più
vicino riverberava nel cielo. Trovarono quasi subito la strada: “asfaltata, ben tenuta; qui è diverso che da
noi”, ma per la verità se l’aspettavano più ampia, più dritta. Se ne tennero fuori, ad evitare incontri: la
seguivano camminando tra gli alberi.
Passò un’automobile: “pare una seicento”; e poi un’altra che pareva una millecento, e un’altra ancora:
“le nostre macchine loro le tengono per capriccio, le comprano ai ragazzi come da noi le biciclette”. Poi
passarono, assordanti, due motociclette, una dietro l’altra. Era la polizia, non c’era da sbagliare: meno
male che si erano tenuti fuori della strada.
Ed ecco che finalmente c’erano le frecce. Guardarono avanti e indietro, entrarono nella strada, si
avvicinarono a leggere: Santa Croce Camerina – Scoglitti.
– Santa Croce Camerina: non mi è nuovo, questo nome.
– Pare anche a me; e nemmeno Scoglitti mi è nuovo.
– Forse qualcuno dei nostri parenti ci abitava, forse mio zio prima di trasferirsi a Filadelfìa: che io ricordo
stava in un’altra città, prima di passare a Filadelfìa.
invece che i giorni, poiché le notti erano di atroce promiscuità, soffocanti. Si sentivano immersi nell’odore
di pesce di nafta e di vomito come in un liquido caldo nero bitume. Ne grondavano all’alba, stremati,
quando salivano ad abbeverarsi di luce e di vento. Ma come l’idea del mare era per loro il piano
verdeggiante di messe quando il vento lo sommuove, il mare vero li atterriva: e le viscere gli si strizzavano,
gli occhi dolorosamente verminavano di luce se appena indugiavano a guardare.
Ma all’undicesima notte il signor Melfa li chiamò in coperta: e credettero dapprima che fìtte costellazioni
fossero scese al mare come greggi; ed erano invece paesi, paesi della ricca America che come gioielli
brillavano nella notte. E la notte stessa era un incanto: serena e dolce, una mezza luna che trascorreva tra
una trasparente fauna di nuvole, una brezza che allargava i polmoni.
– Ecco l’America – disse il signor Melfa.
– Non c’è pericolo che sia un altro posto? – domandò uno: poiché per tutto il viaggio aveva pensato che
nel mare non ci sono nè strade nè trazzere, ed era da dio fare la via giusta, senza sgarrare, conducendo
una nave tra cielo ed acqua.
Il signor Melfa lo guardò con compassione, domandò a tutti – E lo avete mai visto, dalle vostre parti, un
orizzonte come questo? E non lo sentite che l’aria è diversa? Non vedete come splendono questi paesi?
Tutti convennero, con compassione e risentimento guardarono quel loro compagno che aveva osato
una così stupida domanda.
– Liquidiamo il conto – disse il signor Melfa.
Si frugarono sotto la camicia, tirarono fuori i soldi.
– Preparate le vostre cose – disse il signor Melfa dopo avere incassato.
Gli ci vollero pochi minuti: avendo quasi consumato le provviste di viaggio, che per patto avevano
dovuto portarsi, non restava loro che un po’ di biancheria e i regali per i parenti d’America: qualche forma
di pecorino qualche bottiglia di vino vecchio qualche ricamo da mettere in centro alla tavola o alle spalliere
dei sofà. Scesero nella barca leggeri leggeri, ridendo e canticchiando; e uno si mise a cantare a gola
aperta, appena la barca si mosse.
E dunque non avete capito niente? – si arrabbiò il signor Melfa. – E dunque mi volete fare passare il
guaio?… Appena vi avrò lasciati a terra potete correre dal primo sbirro che incontrate, e farvi rimpatriare
con la prima corsa: io me ne fotto, ognuno è libero di ammazzarsi come vuole… E poi, sono stato ai patti:
qui c’è l’America, il dovere mio di buttarvici l’ho assolto… Ma datemi il tempo di tornare a bordo, Cristo di
Dio!
Gli diedero più del tempo di tornare a bordo: che rimasero seduti sulla fresca sabbia, indecisi, senza
saper che fare, benedicendo e maledicendo la notte: la cui protezione, mentre stavano fermi sulla
spiaggia, si sarebbe mutata in terribile agguato se avessero osato allontanarsene.
Il signor Melfa aveva raccomandato – sparpagliatevi – ma nessuno se la sentiva di dividersi dagli altri. E
Trenton chi sa quant’era lontana, chi sa quando ci voleva per arrivarci.
Sentirono, lontano e irreale, un canto. “Sembra un carrettiere nostro”, pensarono: e che il mondo è
ovunque lo stesso, ovunque l’uomo spreme in canto la stessa malinconia, la stessa pena.
Ma erano in America, le città che baluginavano dietro l’orizzonte di sabbia e d’alberi erano città
dell’America.
Due di loro decisero di andare in avanscoperta. Camminarono in direzione della luce che il paese più
vicino riverberava nel cielo. Trovarono quasi subito la strada: “asfaltata, ben tenuta; qui è diverso che da
noi”, ma per la verità se l’aspettavano più ampia, più dritta. Se ne tennero fuori, ad evitare incontri: la
seguivano camminando tra gli alberi.
Passò un’automobile: “pare una seicento”; e poi un’altra che pareva una millecento, e un’altra ancora:
“le nostre macchine loro le tengono per capriccio, le comprano ai ragazzi come da noi le biciclette”. Poi
passarono, assordanti, due motociclette, una dietro l’altra. Era la polizia, non c’era da sbagliare: meno
male che si erano tenuti fuori della strada.
Ed ecco che finalmente c’erano le frecce. Guardarono avanti e indietro, entrarono nella strada, si
avvicinarono a leggere: Santa Croce Camerina – Scoglitti.
– Santa Croce Camerina: non mi è nuovo, questo nome.
– Pare anche a me; e nemmeno Scoglitti mi è nuovo.
– Forse qualcuno dei nostri parenti ci abitava, forse mio zio prima di trasferirsi a Filadelfìa: che io ricordo
stava in un’altra città, prima di passare a Filadelfìa.
– Anche mio fratello: stava in un altro posto, prima di andarsene a Brucchilin… Ma come si chiamasse,
proprio non lo ricordo: e poi, noi leggiamo Santa Croce Camerina, leggiamo Scoglitti; ma come leggono
loro non lo sappiamo, l’americano non si legge come è scritto.
– Già, il bello dell’italiano è questo: che tu come è scritto lo leggi… Ma non è che possiamo passare qui
la nottata, bisogna farsi coraggio… Io la prima macchina che passa, la fermo: domanderò solo “Trenton?”…
Qui la gente è più educata. Anche a non capire quello che dice, gli scapperà un gesto, un segnale: e
almeno capiremo da che parte è, questa maledetta Trenton.
Dalla curva, a venti metri, sbucò una cinquecento: l’automobilista se li vide guizzare davanti, le mani
alzate a fermarlo. Frenò bestemmiando: non pensò a una rapina, che la zona era tra le più calme; credette
volessero un passaggio, aprì lo sportello.
– Trenton? – domandò uno dei due.
– Che? – fece l’automobilista.
– Trenton?
– Che Trenton della madonna – imprecò l’uomo dell’ automobile.
– Parla italiano – si dissero i due, guardandosi per consultarsi: se non era il caso di rivelare a un
compatriota la loro condizione.
L’automobilista chiuse lo sportello, rimise in moto. L’automobile balzò in avanti: e solo allora gridò ai
due che rimanevano sulla strada come statue – ubriaconi, cornuti ubriaconi, cornuti e figli di… – il resto si
perse nella corsa.
Il silenzio dilagò.
– Mi sto ricordando – disse dopo un momento quello cui il nome di Santa Croce non suonava nuovo – a
Santa Croce Camerina, un’annata che dalle nostre parti andò male, mio padre ci venne per la mietitura.
Si buttarono come schiantati sull’orlo della cunetta perché non c’era fretta di portare agli altri la notizia
che erano sbarcati in Sicilia.
Tratto da : Leonardo Sciascia, Il mare colore del vino, Torino, 1973, pp. 19-26
proprio non lo ricordo: e poi, noi leggiamo Santa Croce Camerina, leggiamo Scoglitti; ma come leggono
loro non lo sappiamo, l’americano non si legge come è scritto.
– Già, il bello dell’italiano è questo: che tu come è scritto lo leggi… Ma non è che possiamo passare qui
la nottata, bisogna farsi coraggio… Io la prima macchina che passa, la fermo: domanderò solo “Trenton?”…
Qui la gente è più educata. Anche a non capire quello che dice, gli scapperà un gesto, un segnale: e
almeno capiremo da che parte è, questa maledetta Trenton.
Dalla curva, a venti metri, sbucò una cinquecento: l’automobilista se li vide guizzare davanti, le mani
alzate a fermarlo. Frenò bestemmiando: non pensò a una rapina, che la zona era tra le più calme; credette
volessero un passaggio, aprì lo sportello.
– Trenton? – domandò uno dei due.
– Che? – fece l’automobilista.
– Trenton?
– Che Trenton della madonna – imprecò l’uomo dell’ automobile.
– Parla italiano – si dissero i due, guardandosi per consultarsi: se non era il caso di rivelare a un
compatriota la loro condizione.
L’automobilista chiuse lo sportello, rimise in moto. L’automobile balzò in avanti: e solo allora gridò ai
due che rimanevano sulla strada come statue – ubriaconi, cornuti ubriaconi, cornuti e figli di… – il resto si
perse nella corsa.
Il silenzio dilagò.
– Mi sto ricordando – disse dopo un momento quello cui il nome di Santa Croce non suonava nuovo – a
Santa Croce Camerina, un’annata che dalle nostre parti andò male, mio padre ci venne per la mietitura.
Si buttarono come schiantati sull’orlo della cunetta perché non c’era fretta di portare agli altri la notizia
che erano sbarcati in Sicilia.
Tratto da : Leonardo Sciascia, Il mare colore del vino, Torino, 1973, pp. 19-26